Fra nazionalismo e cattolicesimo: Alle radici del pensiero autonomistico – Pt. 2
Il passaggio dall’età moderna a quella contemporanea, ed in particolare coi processi di decolonizzazione maturati nel novecento e le ideologie che li hanno accompagnati, hanno determinato uno sviluppo del pensiero autonomistico mai intrapreso prima nella storia dell’umanità. Nazionalismo, cattolicesimo, comunismo e libertarianismo sono stati alcuni dei principali campi di pensiero nei quali si sono articolate le varie espressioni della libertà, talvolta solo annunciata e non esercitata. Proseguiamo quindi il percorso avviato nella prima parte (“Fra costituzionalismo e liberalismo: Alle radici del pensiero autonomistico”), per arrivare fino al presente.
Possiamo circoscrivere a 3 eventi storici in particolare l’epoca che segna il tramonto dell’età moderna e il pieno passaggio a quella contemporanea, e che si snoda per oltre un cinquantennio fra due secoli: il primo è indubbiamente il prodotto della rivoluzione francese; il secondo è il Trattato di Portsmouth; il terzo è il discorso dei “Quattordici punti” tenuto dal presidente USA Woodrow Wilson. Vediamo perché, per poi inoltrarci nel vasto pensiero politico-filosofico che ha accompagnato l’ideologia autonomistica.
Fin dall’azione della Lega Lombarda (1167), o della disfatta del Giudicato di Arborea contro le forze catalano-aragonesi (1409), o ancora, dalla rivolta degli attuali Paesi Bassi contro l’amministrazione degli Asburgo di Spagna (1568), una comunità, ed un popolo, identificato in un preciso territorio, tentava l’emancipazione da una amministrazione centrale, e si poneva come antesignano delle prime lotte di liberazione “nazionale” della storia. Ma i sentimenti di rivalsa utilitaristica sono una costante dell’azione umana, nell’antichità vi furono tantissimi episodi al riguardo, come il mito della difesa delle dodici tribù di Israele, la campagna di Alessandro Magno contro la Persia, o la rivolta dei Galli contro l’invasione romana di Giulio Cesare. In età moderna persino il giurista olandese Huig van Groot (1583-1645) viene considerato uno dei precursori dell’autonomismo contemporaneo, in quanto nella sua opera “Mare liberum” istituì una dottrina internazionale che consentì al proprio popolo di spezzare i monopoli commerciali avviati da altre potenze marittime, a favore della propria.
 Nei secoli il concetto di autonomia si è evoluto e, non più motivato unicamente da ragioni amministrative e/o fiscali, ha iniziato ad associarsi maggiormente ad argomentazioni di natura linguistica e culturale. Non dimentichiamoci che parallelamente il capitale cercava di affrancarsi dal dominio dello Stato (Adam Smith, 1723-1790). Dobbiamo considerare che l’odierno concetto di nazione (derivante dal latino “natio”, nascita), è ben diverso da quello dell’antichità, del medioevo, e della prima età moderna. Per il pietismo radicale dello svizzero Beat Ludwig von Muralt (1665-1749) la nazione aveva una connotazione civica e contestuale, che variava da situazione a situazione, e che nei suoi scritti era illustrata dalla differenza fra le libertà elvetiche rispetto al dispotismo francese. Non sono pochi gli autori che identificavano pienamente i popoli in base alle proprie caratteristiche culturali, pensiamo ad esempio nel settecento al giurista scozzese James Boswell ed al suo resoconto sulla Corsica. Sarà il filosofo francese J.J. Rousseau ad attribuire alla massa popolare una volontà generale univoca e volontaristica, del tutto indipendente da quella monarchica, mentre l’abate Emmanuel Joseph Sieyès, tradurrà tale volontà verso una assemblea costituente, associando così all’orientamento collettivo il pieno e incondizionato potere legislativo. Con la rivoluzione francese la nazione dunque seguiva l’affermazione del concetto di Stato, portando le due entità a fondersi. La prima irrompeva nella storia, rendendosi autonoma non più solo da un potere esterno ma interno: la monarchia. La formula del principio dinastico come elemento di formazione e legittimazione dello Stato, rafforzatasi all’epoca di Luigi XIV°, veniva infatti superata dal corpo collettivo del popolo, che rispetto al primo costituzionalismo separava così compiutamente la figura del sovrano quale unico detentore delle chiavi del Regno.
Nei secoli il concetto di autonomia si è evoluto e, non più motivato unicamente da ragioni amministrative e/o fiscali, ha iniziato ad associarsi maggiormente ad argomentazioni di natura linguistica e culturale. Non dimentichiamoci che parallelamente il capitale cercava di affrancarsi dal dominio dello Stato (Adam Smith, 1723-1790). Dobbiamo considerare che l’odierno concetto di nazione (derivante dal latino “natio”, nascita), è ben diverso da quello dell’antichità, del medioevo, e della prima età moderna. Per il pietismo radicale dello svizzero Beat Ludwig von Muralt (1665-1749) la nazione aveva una connotazione civica e contestuale, che variava da situazione a situazione, e che nei suoi scritti era illustrata dalla differenza fra le libertà elvetiche rispetto al dispotismo francese. Non sono pochi gli autori che identificavano pienamente i popoli in base alle proprie caratteristiche culturali, pensiamo ad esempio nel settecento al giurista scozzese James Boswell ed al suo resoconto sulla Corsica. Sarà il filosofo francese J.J. Rousseau ad attribuire alla massa popolare una volontà generale univoca e volontaristica, del tutto indipendente da quella monarchica, mentre l’abate Emmanuel Joseph Sieyès, tradurrà tale volontà verso una assemblea costituente, associando così all’orientamento collettivo il pieno e incondizionato potere legislativo. Con la rivoluzione francese la nazione dunque seguiva l’affermazione del concetto di Stato, portando le due entità a fondersi. La prima irrompeva nella storia, rendendosi autonoma non più solo da un potere esterno ma interno: la monarchia. La formula del principio dinastico come elemento di formazione e legittimazione dello Stato, rafforzatasi all’epoca di Luigi XIV°, veniva infatti superata dal corpo collettivo del popolo, che rispetto al primo costituzionalismo separava così compiutamente la figura del sovrano quale unico detentore delle chiavi del Regno.
Successivamente, il romanticismo del filosofo J. G. Herder attribuirà ai popoli caratteristiche biologiche univoche (sulla scorta di una visione nazionalista che la politologia oggi definisce di tipo etnico), superando la sola visione civica – e tutt’al più geografica – che fino ad allora distingueva, oltre che per lingua, le varie comunità stanziali. Sarà proprio la dimensione basata sullo jus sanguinis a determinare il criterio su cui si svilupperà a posteriori il titolo della cittadinanza nei moderni Stati-nazione, e limitatamente, nello jus soli, al fine di tutelare l’omogeneità linguistica, culturale, talvolta religiosa, e “razziale”, della comunità (quest’ultimo concetto stava alla base della retorica nazionalista presente nei maggiori Stati colonialisti dell’ottocento, prevalentemente associato al primato dell’uomo bianco). Il nazionalismo ottocentesco, condensato da una letteratura di matrice razziale (Blumenbach, de Gobineau e Chamberlain), perpetuò il colonialismo già avviato nel cinquecento grazie alle scoperte geografiche. A ciò si contrapponeva una letteratura dedita a contestare l’ipocrisia occidentale nei confronti dello sfruttamento di popoli completamenti privati della loro autonomia, pensiamo all’opera del vescovo Bartolomé de Las Casas, o nell’ottocento alla satira di Multatuli, che denunciò lo schiavismo nell’Indonesia olandese. Parte della letteratura razziale avrà riflessi anche nell’ampio movimento pangermanista, in cui si annoverano comunque padri nobili del calibro di Hegel e Fichte.
Nel 1882 spetta al filologo Ernest Renan, grazie alla sua disamina del concetto di nazione, il merito di offrirne una visione moderna, che al pari di politologi quali Anthony D. Smith e W. Connor, vedrà negli elementi “spirituali” e volontaristici il primo indicatore dell’esistenza di una nazione come elemento privilegiato per distinguere un popolo da un altro.
 Se da un lato il concetto di autonomia (e di sovranità) andava saldandosi a quello di nazione, generando i primi sentimenti nazionalisti, dall’altro analoghi sentimenti consentivano a vari popoli di affermare la propria autonomia amministrativa e culturale nella propria sfera geografica, con annessi interessi strategici ed economici. Saranno queste le premesse che per tutto il novecento porteranno ai processi di decolonizzazione. Sul piano internazionale, il primo documento che sigilla la nascita di questa nuova visione autonomistica è il Trattato di Portsmouth, che pone fine alla guerra russo-giapponese del biennio 1904/5. La vittoria giapponese sulla flotta russa segna definitivamente la fine dell’eurocentrismo: il primato delle nazioni europee che fino ad allora avevano imperato nella spartizione per aree di influenza nel globo. Se escludiamo infatti l’indipendenza USA nei confronti dell’Inghilterra (1776), l’indipendenza argentina nei confronti della Spagna (1810), quella brasiliana dal Portogallo (1822) e di altri Stati centro-sudamericani, gestite da popolazioni derivanti dal colonialismo europeo, per la prima volta un popolo autoctono usciva con successo da un confronto militare con il potere dominante. La vittoria fornirà lo stimolo per la dottrina riassunta nello slogan “L’Asia agli asiatici”, che grande seguito avrà, anche con le drammatiche conseguenze del militarismo nipponico, nel corso del secondo conflitto mondiale. E più tardi con le guerre di Corea e Indocina. Analoga ideologia patriottica, poi declinata verso una formula imperialista, venne adottata negli USA fin dal 1823 con la “Dottrina Monroe”, che proclamava il concetto “L’America agli americani”, sebbene la non ingerenza negli affari europei includesse inizialmente anche le colonie dei vecchi imperi nel “nuovo mondo”. Eppure, ci furono in realtà altri due episodi bellici che incrinarono la pretesa superiorità europea a scapito dei popoli colonizzati: la battaglia di Isandlwana, del 1879, quando l’imperialismo britannico venne sconfitto dalle forze africane Zulu, e la battaglia di Adua, del 1896, quando il regio esercito italiano venne travolto dalle forze abissine dell’Etiopia.
Se da un lato il concetto di autonomia (e di sovranità) andava saldandosi a quello di nazione, generando i primi sentimenti nazionalisti, dall’altro analoghi sentimenti consentivano a vari popoli di affermare la propria autonomia amministrativa e culturale nella propria sfera geografica, con annessi interessi strategici ed economici. Saranno queste le premesse che per tutto il novecento porteranno ai processi di decolonizzazione. Sul piano internazionale, il primo documento che sigilla la nascita di questa nuova visione autonomistica è il Trattato di Portsmouth, che pone fine alla guerra russo-giapponese del biennio 1904/5. La vittoria giapponese sulla flotta russa segna definitivamente la fine dell’eurocentrismo: il primato delle nazioni europee che fino ad allora avevano imperato nella spartizione per aree di influenza nel globo. Se escludiamo infatti l’indipendenza USA nei confronti dell’Inghilterra (1776), l’indipendenza argentina nei confronti della Spagna (1810), quella brasiliana dal Portogallo (1822) e di altri Stati centro-sudamericani, gestite da popolazioni derivanti dal colonialismo europeo, per la prima volta un popolo autoctono usciva con successo da un confronto militare con il potere dominante. La vittoria fornirà lo stimolo per la dottrina riassunta nello slogan “L’Asia agli asiatici”, che grande seguito avrà, anche con le drammatiche conseguenze del militarismo nipponico, nel corso del secondo conflitto mondiale. E più tardi con le guerre di Corea e Indocina. Analoga ideologia patriottica, poi declinata verso una formula imperialista, venne adottata negli USA fin dal 1823 con la “Dottrina Monroe”, che proclamava il concetto “L’America agli americani”, sebbene la non ingerenza negli affari europei includesse inizialmente anche le colonie dei vecchi imperi nel “nuovo mondo”. Eppure, ci furono in realtà altri due episodi bellici che incrinarono la pretesa superiorità europea a scapito dei popoli colonizzati: la battaglia di Isandlwana, del 1879, quando l’imperialismo britannico venne sconfitto dalle forze africane Zulu, e la battaglia di Adua, del 1896, quando il regio esercito italiano venne travolto dalle forze abissine dell’Etiopia.
 Ma oltre alla guerra russo-giapponese vi fu un evento bellico di dimensioni mondiali che consentì ai popoli oppressi di affrancarsi dal giogo della dominazione, determinando nel Diritto Internazionale il primo chiaro enunciato a favore delle singole nazioni. Si tratta dei “Quattordici punti” di Woodrow Wilson, che, ben prima della Società delle Nazioni, costituiranno anche la base ideologica delle future Nazioni Unite, e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948). Al termine della prima guerra mondiale, il presidente statunitense Wilson affermò che i Trattati deputati a ricostruire l’equilibrio politico europeo avrebbero dovuto tenere conto delle legittime aspirazioni nazionali dei vari popoli (si deve a questa linea ad esempio la rinascita di una Polonia sovrana).
Ma oltre alla guerra russo-giapponese vi fu un evento bellico di dimensioni mondiali che consentì ai popoli oppressi di affrancarsi dal giogo della dominazione, determinando nel Diritto Internazionale il primo chiaro enunciato a favore delle singole nazioni. Si tratta dei “Quattordici punti” di Woodrow Wilson, che, ben prima della Società delle Nazioni, costituiranno anche la base ideologica delle future Nazioni Unite, e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948). Al termine della prima guerra mondiale, il presidente statunitense Wilson affermò che i Trattati deputati a ricostruire l’equilibrio politico europeo avrebbero dovuto tenere conto delle legittime aspirazioni nazionali dei vari popoli (si deve a questa linea ad esempio la rinascita di una Polonia sovrana).
Con il conflitto crollarono ben tre imperi, quello tedesco (che al suo interno contemplava un assetto federale sbilanciato a favore della Prussia), quello austro-ungarico (in cui il dualismo nazionale non soddisfaceva le altre componenti slave e non), e quello ottomano, sprigionando le pulsioni nazionaliste e indipendentiste già presenti all’interno dei vari popoli che li componevano. Fu l’epoca in cui un insigne giurista come James Bryce, teorico del costituzionalismo flessibile (cioè caratterizzato da ampie possibilità di riforma), si poneva l’interrogativo su quale assetto internazionale fornire affinché ogni singola nazione non fosse soggetta al giogo di altre, schierandosi in particolar modo a favore della minoranza armena (all’epoca sottoposta ai massacri dello sciovinismo turco), e della questione irlandese, che nel 1922, grazie all’impegno di patrioti come Michael Collins, portò la Gran Bretagna a rinunciare al dominio su 26 delle 32 contee occupate da Londra, lasciando dunque irrisolta la questione dell’Ulster.
 Il criterio dell’autodeterminazione nazionale evocato da Wilson diventerà così una costante per tutte le successive rivendicazioni nazionali che si alterneranno nel corso del novecento, fornendo nuova legittimazione anche a fenomeni nazionalistici extraterritoriali. Fra i maggiori abbiamo il panarabismo, sviluppatosi in Medio Oriente, ed il sionismo, nato fra gli emigrati ebrei in Europa, entrambi sorti a cavallo fra i due secoli scorsi. Il primo promulgava l’emancipazione delle singole autonomie arabofone dal giogo ottomano, e successivamente al crollo della “Sublime Porta”, il panarabismo politico si orientò contro il colonialismo occidentale, che si era ormai stabilmente introdotto negli ex territori ottomani (in particolare dopo l’Accordo Sykes-Picot fra Inghilterra e Francia del 1916). Fondato da vari intellettuali come Negib Azoury e Michel Aflaq (quest’ultimo fondatore del partito Ba’th), il panarabismo assorbì elementi dell’antisemitismo francese e nel tempo si divise in due rami: uno conservatore, rappresentato politicamente dalla Fratellanza Musulmana (di matrice islamica e inquadrata nell’area egiziana), ed uno laico, rappresentato dal Ba’th (di matrice socialista, inquadrato nell’area siriana ed irachena). Durante la guerra fredda il nazionalismo panarabista porterà il presidente egiziano Gamal Abd el-Nasser a porsi come leader della Repubblica Araba Unita di Siria ed Egitto (una esperienza istituzionale durata dal 1961 al 1971). Entrambi i rami del panarabismo menzionati avranno pesanti influenze nell’irrisolta questione palestinese e nell’utilizzo del terrorismo come strumento di affermazione politica. Specularmente, il sionismo si proponeva inizialmente di fornire maggiore autonomia politica e religiosa agli ebrei nei Paesi in cui tali emigrati erano presenti, spesso da generazioni. Successivamente si è evoluto, ed in particolar modo dopo lo sterminio nazista del secondo conflitto mondiale, verso la creazione di uno Stato ebraico in terra di Palestina, ex protettorato britannico (che arriverà nel 1948 e che, nato in assenza di sovranità del popolo palestinese nel medesimo territorio rivendicato da tutte le fazioni, sarà causa di frizioni del mondo arabo). Come nel panarabismo, anche il sionismo assumerà la lingua, la religione, la cultura e la storia come elementi di coesione sociale su cui fondare la richiesta di una propria autonomia nazionale. Fra i massimi esponenti del sionismo si annoverano Leon Pinsker e Theodor Herzl.
Il criterio dell’autodeterminazione nazionale evocato da Wilson diventerà così una costante per tutte le successive rivendicazioni nazionali che si alterneranno nel corso del novecento, fornendo nuova legittimazione anche a fenomeni nazionalistici extraterritoriali. Fra i maggiori abbiamo il panarabismo, sviluppatosi in Medio Oriente, ed il sionismo, nato fra gli emigrati ebrei in Europa, entrambi sorti a cavallo fra i due secoli scorsi. Il primo promulgava l’emancipazione delle singole autonomie arabofone dal giogo ottomano, e successivamente al crollo della “Sublime Porta”, il panarabismo politico si orientò contro il colonialismo occidentale, che si era ormai stabilmente introdotto negli ex territori ottomani (in particolare dopo l’Accordo Sykes-Picot fra Inghilterra e Francia del 1916). Fondato da vari intellettuali come Negib Azoury e Michel Aflaq (quest’ultimo fondatore del partito Ba’th), il panarabismo assorbì elementi dell’antisemitismo francese e nel tempo si divise in due rami: uno conservatore, rappresentato politicamente dalla Fratellanza Musulmana (di matrice islamica e inquadrata nell’area egiziana), ed uno laico, rappresentato dal Ba’th (di matrice socialista, inquadrato nell’area siriana ed irachena). Durante la guerra fredda il nazionalismo panarabista porterà il presidente egiziano Gamal Abd el-Nasser a porsi come leader della Repubblica Araba Unita di Siria ed Egitto (una esperienza istituzionale durata dal 1961 al 1971). Entrambi i rami del panarabismo menzionati avranno pesanti influenze nell’irrisolta questione palestinese e nell’utilizzo del terrorismo come strumento di affermazione politica. Specularmente, il sionismo si proponeva inizialmente di fornire maggiore autonomia politica e religiosa agli ebrei nei Paesi in cui tali emigrati erano presenti, spesso da generazioni. Successivamente si è evoluto, ed in particolar modo dopo lo sterminio nazista del secondo conflitto mondiale, verso la creazione di uno Stato ebraico in terra di Palestina, ex protettorato britannico (che arriverà nel 1948 e che, nato in assenza di sovranità del popolo palestinese nel medesimo territorio rivendicato da tutte le fazioni, sarà causa di frizioni del mondo arabo). Come nel panarabismo, anche il sionismo assumerà la lingua, la religione, la cultura e la storia come elementi di coesione sociale su cui fondare la richiesta di una propria autonomia nazionale. Fra i massimi esponenti del sionismo si annoverano Leon Pinsker e Theodor Herzl.
Altro celebre nazionalismo extraterritoriale fu ad esempio quello della “negritudine”, sviluppatosi grazie ad intellettuali come Léopold Sédar Senghor ed Aimé Césaire, per promuovere le peculiarità dei popoli neri rispetto all’opera dei colonizzatori bianchi.
Mentre uno psicologo del calibro di Frantz Fanon analizzò i comportamenti dei neri colonizzati in rapporto al razzismo francese, coniando la terminologia del “terzo mondo”, riferita a tutti quei Paesi da avviare allo sviluppo, rispetto al bipolarismo USA-URSS.
 Ancora oggi nel mondo arabo la religione continua a fornire un supporto ideologico al nazionalismo arabo ed ai movimenti antisionistici islamici. Analoga funzione di coesione sociale è stata svolta in occidente dal cattolicesimo per vari secoli, fino a configurarsi come una vera e propria spinta dogmatica della battaglia per l’autonomia della civiltà europea nel confronto con l’Islam. In particolare nel 1529, quando l’assedio ottomano di Vienna si risolse in una disfatta a favore delle potenze cristiane (con le stesse sorti della battaglia del 1683), e nel 1571, quando la Lega Santa di Giovanni d’Austria sconfisse la flotta ottomana nella battaglia di Lepanto. Mentre per tutta l’età moderna, fino al novecento, il cattolicesimo è stato lo strumento che ha consentito al nazionalismo irlandese di preservare la propria identità rispetto all’anglicanesimo inglese, configurandosi come strumento di tutela dell’individuo e delle minoranze nazionali. In Italia sarà il riformismo cattolico di matrice liberale a farsi carico per primo delle singole sensibilità territoriali, in un contesto storico che vedeva la Chiesa arretrare rispetto all’affermazione dello Stato ottocentesco, e che pertanto riscopriva la vocazione al ripristino dell’antica pluralità degli ordinamenti come strumento per temperare l’assolutismo statale. Il cattolicesimo di uomini come Antonio Rosmini propagandò la soluzione federale per mitigare il centralismo del Regno d’Italia, seguito, senza successo, da Vincenzo Gioberti (“neoguelfista”), dal Sardo Giovanni Battista Tuveri (vicino alla soluzione svizzera), e più tardi da Luigi Sturzo, padre del popolarismo italiano, che nel secondo dopoguerra si batterà per la tutela dell’autonomismo nel futuro assetto regionalista della Repubblica. Da ricordare la figura di Luigi Taparelli d’Azeglio, gesuita che in epoca risorgimentale propugnò il concetto della giustizia sociale, ripreso dall’enciclica “Rerum novarum” di Papa Leone XIII° (che introdusse il principio della sussidiarietà), e si schierò col diritto all’indipendenza della Sicilia. In Francia dopo la seconda guerra mondiale il cattolico Emmanuel Mounier sarà in prima fila, accanto all’italiano Altiero Spinelli, per immaginare una federazione sovranazionale di Stati, che di lì a poco tuttavia avrebbe assunto connotati sempre più centralistici con la nascita dell’Europa unita promossa da Schumann, Adenauer ed altri statisti europei. Importante federalista fu anche il filosofo cattolico Jacques Maritain, esponente del neotomismo.
Ancora oggi nel mondo arabo la religione continua a fornire un supporto ideologico al nazionalismo arabo ed ai movimenti antisionistici islamici. Analoga funzione di coesione sociale è stata svolta in occidente dal cattolicesimo per vari secoli, fino a configurarsi come una vera e propria spinta dogmatica della battaglia per l’autonomia della civiltà europea nel confronto con l’Islam. In particolare nel 1529, quando l’assedio ottomano di Vienna si risolse in una disfatta a favore delle potenze cristiane (con le stesse sorti della battaglia del 1683), e nel 1571, quando la Lega Santa di Giovanni d’Austria sconfisse la flotta ottomana nella battaglia di Lepanto. Mentre per tutta l’età moderna, fino al novecento, il cattolicesimo è stato lo strumento che ha consentito al nazionalismo irlandese di preservare la propria identità rispetto all’anglicanesimo inglese, configurandosi come strumento di tutela dell’individuo e delle minoranze nazionali. In Italia sarà il riformismo cattolico di matrice liberale a farsi carico per primo delle singole sensibilità territoriali, in un contesto storico che vedeva la Chiesa arretrare rispetto all’affermazione dello Stato ottocentesco, e che pertanto riscopriva la vocazione al ripristino dell’antica pluralità degli ordinamenti come strumento per temperare l’assolutismo statale. Il cattolicesimo di uomini come Antonio Rosmini propagandò la soluzione federale per mitigare il centralismo del Regno d’Italia, seguito, senza successo, da Vincenzo Gioberti (“neoguelfista”), dal Sardo Giovanni Battista Tuveri (vicino alla soluzione svizzera), e più tardi da Luigi Sturzo, padre del popolarismo italiano, che nel secondo dopoguerra si batterà per la tutela dell’autonomismo nel futuro assetto regionalista della Repubblica. Da ricordare la figura di Luigi Taparelli d’Azeglio, gesuita che in epoca risorgimentale propugnò il concetto della giustizia sociale, ripreso dall’enciclica “Rerum novarum” di Papa Leone XIII° (che introdusse il principio della sussidiarietà), e si schierò col diritto all’indipendenza della Sicilia. In Francia dopo la seconda guerra mondiale il cattolico Emmanuel Mounier sarà in prima fila, accanto all’italiano Altiero Spinelli, per immaginare una federazione sovranazionale di Stati, che di lì a poco tuttavia avrebbe assunto connotati sempre più centralistici con la nascita dell’Europa unita promossa da Schumann, Adenauer ed altri statisti europei. Importante federalista fu anche il filosofo cattolico Jacques Maritain, esponente del neotomismo.
Nell’Italia post-risorgimentale, uno dei maggiori esponenti federalisti assieme a Giuseppe Ferrari fu Carlo Cattaneo, che definì impropria la scelta di aver creato uno Stato-nazione italiano, alla luce delle diverse condizioni sociali, culturali ed economiche che distinguevano i territori del nuovo Regno sabaudo. Sul piano legislativo invece si distinsero in ambito regionalista, fra i vari, Luigi Carlo Farini e Marco Minghetti, inascoltati. Altri ancora, come il liberale Piero Gobetti (1901-1926), propugnavano una maggiore autonomia dalla burocrazia di Stato che in Italia era emersa come principale fattore di coesione sociale ed istituzionale sotto i governi di Crispi, e soprattutto durante l’età giolittiana; mentre meridionalisti come Gaetano Salvemini (1873-1957) ed il Sardo Attilio Deffenu (1890-1918) sostenevano una visione federalista ed autonomista come unica possibile soluzione amministrativa per ridurre i divari allo sviluppo che separavano le popolazioni dell’Italia unita.
 Nel corso dell’ottocento non furono solo nazionalismo, liberalismo e cattolicesimo a porre le basi di un sentimento autonomistico sviluppatosi nel secolo successivo, ma anche l’anarchismo. Si deve al francese Pierre-Joseph Proudhon una delle più decise contestazioni alla natura dello Stato centrale, riconoscendo al solo federalismo, connotato in termini integrali, con assenza dello Stato, l’unico strumento di self-government consentito. Con riferimento allo Stato-nazione francese, Proudhon ne contestò il mito unitarista, ricordando che lo Stato era formato in realtà da circa 15 nazionalità, fra cui quella bretone e occitana. Il suo pensiero è inquadrabile nell’ampia galassia del libertarismo internazionale, lanciata dal comunista anarchico Joseph Déjacque nel 1857, in cui il caposaldo concettuale identifica la totale libertà ed autonomia dell’individuo dal potere dello Stato. Proudhon influirà nel federalismo integrale di intellettuali come Alexandre Marc, Denis De Rougemont ed anche Alain de Benoist.
Nel corso dell’ottocento non furono solo nazionalismo, liberalismo e cattolicesimo a porre le basi di un sentimento autonomistico sviluppatosi nel secolo successivo, ma anche l’anarchismo. Si deve al francese Pierre-Joseph Proudhon una delle più decise contestazioni alla natura dello Stato centrale, riconoscendo al solo federalismo, connotato in termini integrali, con assenza dello Stato, l’unico strumento di self-government consentito. Con riferimento allo Stato-nazione francese, Proudhon ne contestò il mito unitarista, ricordando che lo Stato era formato in realtà da circa 15 nazionalità, fra cui quella bretone e occitana. Il suo pensiero è inquadrabile nell’ampia galassia del libertarismo internazionale, lanciata dal comunista anarchico Joseph Déjacque nel 1857, in cui il caposaldo concettuale identifica la totale libertà ed autonomia dell’individuo dal potere dello Stato. Proudhon influirà nel federalismo integrale di intellettuali come Alexandre Marc, Denis De Rougemont ed anche Alain de Benoist.
Il mito con cui lo Stato-nazione legittima la sua esistenza (che affascinò anche Mazzini e Garibaldi), e sfrutta la coercizione delle minoranze presenti entro i suoi confini, è stato ampiamente illustrato da vari autori, fra cui il politologo Daniel J. Elazar (1934-1999), che nel suo studio sul federalismo menzionò il caso italiano, dove una vera e propria guerra di conquista, condotta dal Regno di Sardegna (piemontese de facto), rovesciò la monarchia borbonica nella penisola del sud. Pensiamo anche alle pubblicazioni di Nicola Zitara, che associò all’opera piemontese in Sicilia una autentica azione colonialista (1971). Mentre il filosofo federalista Mario Albertini (1919-1997) tracciò le caratteristiche con cui lo Stato-nazione alimenta il suo mito, attraverso la centralizzazione della forza e della cultura, dove polizia e scuola non rispondono più ad esigenze territoriali e lo scopo diviene la piena omologazione e assimilazione al centro di tutte le minoranze, che gradualmente vengono annullate. La conseguenza è che lo Stato nazionale, secondo una sua efficace definizione, si pone come “il padrone della coscienza degli individui”, determinando una paradossale realtà, in cui un palermitano viene culturalmente assimilato ad un torinese, quando quest’ultimo è culturalmente più vicino ad un lionese. Analoga posizione venne sostenuta dal socialista veneto Silvio Trentin durante il ventennio fascista, mentre l’antifascista Sardo Emilio Lussu si batterà per la creazione di una Italia federale su base socialista, a prescindere da qualsiasi orientamento linguistico (aspetto che invece contrassegnava l’autonomismo sudtirolese nella fase post-bellica). Si deve al giurista Gianfranco Miglio (1918-2001) il rilancio di un riformismo politico in senso federale dell’Italia, dopo la sfortunata esperienza dell’azionismo, fallito fin dai primi anni di vita della Repubblica.
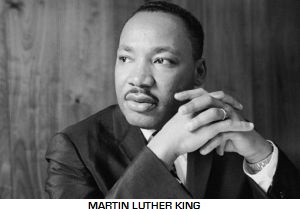 Ad oggi in Italia continuano ad esistere vari movimenti per l’autodeterminazione nazionale, e alternatisi fra alti e bassi alla ribalta dell’opinione pubblica: fra cui quello siciliano, veneto, Sardo (fra i maggiori), valdostano, sudtirolese (che nelle prime fasi fu contrassegnato da azioni terroristiche, come quelle del BAS, fondato nel 1956), etc., oltre al movimento macroregionale della Lega Nord. La Sardegna in particolare conquistò la sua autonomia grazie al movimento sardista, fondato da Camillo Bellieni, con la terza legge costituzionale del 1948. E fin da subito la Lega Sarda di Bastià Pirisi propose, con scarso successo elettorale, la piena indipendenza dell’isola.
Ad oggi in Italia continuano ad esistere vari movimenti per l’autodeterminazione nazionale, e alternatisi fra alti e bassi alla ribalta dell’opinione pubblica: fra cui quello siciliano, veneto, Sardo (fra i maggiori), valdostano, sudtirolese (che nelle prime fasi fu contrassegnato da azioni terroristiche, come quelle del BAS, fondato nel 1956), etc., oltre al movimento macroregionale della Lega Nord. La Sardegna in particolare conquistò la sua autonomia grazie al movimento sardista, fondato da Camillo Bellieni, con la terza legge costituzionale del 1948. E fin da subito la Lega Sarda di Bastià Pirisi propose, con scarso successo elettorale, la piena indipendenza dell’isola.
Va considerato che l’attuale assetto repubblicano nasceva al termine della seconda guerra mondiale anche a causa della nuova linea di politica internazionale assunta dagli Stati Uniti in ragione dell’emergente minaccia comunista. Se della vecchia proposta Wilson si elevavano i principi su cui nacquero le Nazioni Unite (1945), per contro, come nelle conseguenze della prima guerra mondiale, anche stavolta l’orientamento prevalente tese ad evitare la completa dissoluzione degli Stati usciti sconfitti dal conflitto, impedendo la nascita di nuovi Stati più piccoli, nella convinzione che Paesi voluminosi avrebbero contribuito a rallentare l’espansione del comunismo in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Sconfessando fin da subito i propositi di Wilson. Nel corso della sua storia, il governo federale USA non assunse solo l’orientamento di minare l’autonomia dei popoli all’esterno, ma persino all’interno della propria federazione e contro la libera iniziativa. Nel primo caso a scapito di tutte le minoranze etniche del nord America, fra cui i nativi, e le popolazioni di colore (che solo negli anni ’60 del novecento, grazie all’opera delle presidenze Kennedy/Johnson e dell’attivismo di uomini come Martin Luther King e Malcom X, intraprenderanno un percorso di uscita dalla discriminazione). Nel secondo caso va ricordata la vicenda dell’abolizionista Lysander Spooner, imprenditore nel settore dei servizi postali, che avviò una propria azienda sfidando il vecchio monopolio statale della corrispondenza, e venne costretto dal governo federale a chiudere, ottenendo tuttavia un abbassamento dei prezzi sul mercato.
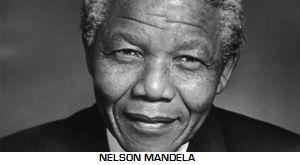 Eppure, benché gli USA del novecento non fossero l’unico Paese a temere l’avanzata del comunismo, rallentando la nascita di nuovi Stati, l’ideologia marxista contribuì in maniera determinante all’affermazione di varie entità nazionali per tutto il secolo, e fornendo anche nuova linfa ideologica ai classici movimenti per l’emancipazione femminile. Mentre in Sardegna Antonio Gramsci si espresse a favore della lingua Sarda, da tempo in Russia il primo leader sovietico Lenin aveva divulgato importanti pagine contro l’imperialismo ed a favore dell’autodeterminazione dei popoli, creando tuttavia nella sua azione politica e rivoluzionaria uno Stato dittatoriale a partito unico che invase diversi Paesi confinanti, fra cui le comunità baltiche e ucraine. Fino all’espansione del totalitarismo avvenuta sotto Stalin, a scapito dell’intera Europa dell’est nel secondo dopoguerra, che venne interamente privata della propria autonomia politica e culturale. Singolare inoltre l’esperienza cubana, che da un lato liberò l’isola dalla dittatura filo-americana di Fulgencio Batista (1959), e dall’altro la consegnò a quella castrista, su cui ebbe un fondamentale ruolo la figura dell’argentino Ernesto Che Guevara, contribuendo ad esportare nel mondo una visione romantica dell’azione rivoluzionaria rispetto a quella riformistica. Dalla Cina maoista fino al continente africano ed a quello sudamericano (che nel novecento rimaneva preda di varie giunte militari di stampo fascista), il mito della rivoluzione socialista influenzò diverse generazioni di giovani, di guerriglieri e di intellettuali. Fra costoro possono essere annoverati anche i seguaci contemporanei del panafricanismo (ideologia similare alla “negritudine”, fondata da Henry Sylvester Williams nel 1900), che nel 1984 portò Thomas Sankara al governo del Burkina Faso, nel tentativo di espugnare l’influenza franco-statunitense nella regione. Da ricordare, Sankara si pronunciò alle Nazioni Unite con uno storico discorso per la liberazione dell’antiapartheid sudafricano Nelson Mandela, all’epoca detenuto dalle autorità di Pretoria. Altro celebre leader filosovietico fu il primo presidente della neonata Repubblica Democratica del Congo Patrice Lumumba (1960), assassinato un anno dopo con il concorso di funzionari belgi.
Eppure, benché gli USA del novecento non fossero l’unico Paese a temere l’avanzata del comunismo, rallentando la nascita di nuovi Stati, l’ideologia marxista contribuì in maniera determinante all’affermazione di varie entità nazionali per tutto il secolo, e fornendo anche nuova linfa ideologica ai classici movimenti per l’emancipazione femminile. Mentre in Sardegna Antonio Gramsci si espresse a favore della lingua Sarda, da tempo in Russia il primo leader sovietico Lenin aveva divulgato importanti pagine contro l’imperialismo ed a favore dell’autodeterminazione dei popoli, creando tuttavia nella sua azione politica e rivoluzionaria uno Stato dittatoriale a partito unico che invase diversi Paesi confinanti, fra cui le comunità baltiche e ucraine. Fino all’espansione del totalitarismo avvenuta sotto Stalin, a scapito dell’intera Europa dell’est nel secondo dopoguerra, che venne interamente privata della propria autonomia politica e culturale. Singolare inoltre l’esperienza cubana, che da un lato liberò l’isola dalla dittatura filo-americana di Fulgencio Batista (1959), e dall’altro la consegnò a quella castrista, su cui ebbe un fondamentale ruolo la figura dell’argentino Ernesto Che Guevara, contribuendo ad esportare nel mondo una visione romantica dell’azione rivoluzionaria rispetto a quella riformistica. Dalla Cina maoista fino al continente africano ed a quello sudamericano (che nel novecento rimaneva preda di varie giunte militari di stampo fascista), il mito della rivoluzione socialista influenzò diverse generazioni di giovani, di guerriglieri e di intellettuali. Fra costoro possono essere annoverati anche i seguaci contemporanei del panafricanismo (ideologia similare alla “negritudine”, fondata da Henry Sylvester Williams nel 1900), che nel 1984 portò Thomas Sankara al governo del Burkina Faso, nel tentativo di espugnare l’influenza franco-statunitense nella regione. Da ricordare, Sankara si pronunciò alle Nazioni Unite con uno storico discorso per la liberazione dell’antiapartheid sudafricano Nelson Mandela, all’epoca detenuto dalle autorità di Pretoria. Altro celebre leader filosovietico fu il primo presidente della neonata Repubblica Democratica del Congo Patrice Lumumba (1960), assassinato un anno dopo con il concorso di funzionari belgi.
Tuttavia, nonostante il supporto del blocco sovietico, l’Africa rimarrà, pur conquistando l’indipendenza in diversi Stati, soggetta all’influenza occidentale, dando luogo all’assenza di qualsiasi reale autonomia dei popoli sottomessi e di volta in volta a spietate dittature, fra cui si annoverano quelle della Repubblica Centrafricana di Jean-Bédel Bokassa (1921-1996) e dell’Uganda di Idi Amin Dada (1925-2003). Lo sciovinismo interno alle comunità etniche africane porterà più tardi a drammatici genocidi come quello del Rwanda (1994). Anche Papa Paolo VI° nel suo pontificato si esprimerà a favore della decolonizzazione.
 Sul fronte balcanico, nella ex Jugoslavia il socialismo di Tito impedirà qualsiasi indipendenza delle proprie minoranze nazionali fino alla sua morte (1980), quando l’etnonazionalismo delle varie comunità locali, in particolare quella serba, esploderà in tutta la sua drammaticità nel corso degli anni ’90, lungo una serie di guerre sanguinose (il Kosovo raggiungerà l’indipendenza solo nel 2008). Per certi versi, il crollo definitivo del blocco socialista (1989/1991), con riferimento all’est europeo (ma non solo), può essere paragonato in termini di rinascita autonomista al tramonto dell’ex Impero Britannico, quando l’indipendenza di varie nazioni dall’amministrazione inglese (nel quadro del Commonwealth ed oltre) ha prodotto in meno di un secolo la nascita di centinaia di nuovi Stati (pensiamo al multinazionale Canada, all’India del nazionalismo non-violento di Gandhi, o nel Mediterraneo alla Repubblica di Malta). In Polonia fu grazie al sindacato cattolico Solidarnosc che si avviò un processo di democratizzazione del Paese e di indipendenza dal regime sovietico, in Ungheria col rilancio dell’autonomia del martire Imre Nagy, in Cecoslovacchia ciò avvenne grazie al movimento Charta ’77 di Vàclav Havel, che in seguito portò lo Stato a dissolversi a favore delle nazioni ceca e slovacca (1993). Anche il crollo dell’ex impero francese ha contribuito all’autodeterminazione di numerosi popoli, in particolare con l’avvento della quinta repubblica di De Gaulle, in cui l’indipendenza algerina del 1962 costituì l’apice del processo di decolonizzazione. Altri popoli nel corso della guerra fredda, e oltre, non muteranno la propria posizione in termini di libertà. Ad esempio la Cecenia, rimasta sotto il controllo russo; o il Kurdistan, che continuerà ad essere una realtà nazionale smembrata fra vari Stati (Iran, Iraq e Turchia). Mentre l’Iran, preda del colonialismo petrolifero occidentale, passerà dal regime autocratico dello scià di Persia alla dittatura khomeinista, assoggettando la popolazione ai precetti di un Islam radicale sciita (1979).
Sul fronte balcanico, nella ex Jugoslavia il socialismo di Tito impedirà qualsiasi indipendenza delle proprie minoranze nazionali fino alla sua morte (1980), quando l’etnonazionalismo delle varie comunità locali, in particolare quella serba, esploderà in tutta la sua drammaticità nel corso degli anni ’90, lungo una serie di guerre sanguinose (il Kosovo raggiungerà l’indipendenza solo nel 2008). Per certi versi, il crollo definitivo del blocco socialista (1989/1991), con riferimento all’est europeo (ma non solo), può essere paragonato in termini di rinascita autonomista al tramonto dell’ex Impero Britannico, quando l’indipendenza di varie nazioni dall’amministrazione inglese (nel quadro del Commonwealth ed oltre) ha prodotto in meno di un secolo la nascita di centinaia di nuovi Stati (pensiamo al multinazionale Canada, all’India del nazionalismo non-violento di Gandhi, o nel Mediterraneo alla Repubblica di Malta). In Polonia fu grazie al sindacato cattolico Solidarnosc che si avviò un processo di democratizzazione del Paese e di indipendenza dal regime sovietico, in Ungheria col rilancio dell’autonomia del martire Imre Nagy, in Cecoslovacchia ciò avvenne grazie al movimento Charta ’77 di Vàclav Havel, che in seguito portò lo Stato a dissolversi a favore delle nazioni ceca e slovacca (1993). Anche il crollo dell’ex impero francese ha contribuito all’autodeterminazione di numerosi popoli, in particolare con l’avvento della quinta repubblica di De Gaulle, in cui l’indipendenza algerina del 1962 costituì l’apice del processo di decolonizzazione. Altri popoli nel corso della guerra fredda, e oltre, non muteranno la propria posizione in termini di libertà. Ad esempio la Cecenia, rimasta sotto il controllo russo; o il Kurdistan, che continuerà ad essere una realtà nazionale smembrata fra vari Stati (Iran, Iraq e Turchia). Mentre l’Iran, preda del colonialismo petrolifero occidentale, passerà dal regime autocratico dello scià di Persia alla dittatura khomeinista, assoggettando la popolazione ai precetti di un Islam radicale sciita (1979).
 In questi stessi anni il Diritto Internazionale ha compiuto importanti passi avanti, offrendo una importante cornice giuridica di aggiornamento nei casi di nascita di nuovi Stati, regolamentandone diritti ed obblighi nella successione della sovranità su un dato territorio. Questo lavoro è stato portato avanti dalla Commissione omonima, un organo sussidiario dell’ONU, e si è tradotto nella Convenzione di Vienna del 1978, e successivamente nei Trattati del 1983 e del 1986. L’unico neo alla sua concreta applicazione è stato il basso numero di ratifiche da parte degli Stati membri, limitatosi inizialmente a 20, vanificandone la completa entrata in vigore, e che denota ancora oggi la chiara difficoltà dei maggiori Stati-nazione mondiali a trattare il tema della secessione e dell’indipendentismo. Diversi altri enunciati internazionali continueranno a riprendere nel tempo il principio dell’autodeterminazione proposto da Wilson all’inizio del XX° secolo, come ad esempio gli Accordi di Helsinki del 1975, dove tuttavia l’obiettivo fondamentale era rappresentato dal miglioramento dei rapporti fra i Paesi NATO e quelli del Patto di Varsavia. Parallelamente, i movimenti indipendentisti nazionali non rimasero inerti e tentarono a più riprese forme di collaborazione internazionale. Peculiare in tal senso fu nel 1974 l’adozione della Carta di Brest, quando i movimenti gallese, occitano, bretone, basco, catalano, irlandese e Sardo (rappresentato da Su Populu Sardu) si riunirono per contestare l’imperialismo, sulla base di una visione marxista-socialista. In Europa tuttavia sorgevano partiti politici indipendentisti sovranazionali dediti a promuovere il tema dell’autodeterminazione, come l’European Free Alliance (Bruxelles, 1981), in cui aderirà anche il Partito Sardo d’Azione. Mentre più tardi il movimento Sardigna Natzione aderirà alle conferenze della CONSEU, una organizzazione dedita alla promozione delle tematiche dei popoli senza Stato dell’Europa occidentale. Sul piano legalitario, lentamente ratificato da numerosi Stati europei, nel quadro del vecchio continente si è consolidata la prassi avviata dalle Nazioni Unite in materia di rispetto delle minoranze (inizialmente con il Consiglio d’Europa, organizzazione esterna all’UE), sia relativamente ad una Carta delle lingue minoritarie (1992/1998), sia con la Convenzione-quadro delle minoranze nazionali (1991/1998), che si colloca sulla linea della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU, 1950). Mentre per l’UE gli standard odierni di tutela si collocano a partire dal Trattato di Nizza (2000), che istituì la Carta dei diritti fondamentali, sul solco della CEDU. Da segnalare inoltre la maggiore ONG internazionale nel campo dei diritti dei popoli senza Stato, l’UNPO, fondata nei Paesi Bassi nel 1991, che racchiude le rappresentanze di numerose minoranze etniche e nazionali, fra cui quella tibetana, abkhaza e taiwanese. Vi sono escluse tutte le partecipazioni politiche che includono l’uso della forza e del terrorismo come strumento di esercizio politico.
In questi stessi anni il Diritto Internazionale ha compiuto importanti passi avanti, offrendo una importante cornice giuridica di aggiornamento nei casi di nascita di nuovi Stati, regolamentandone diritti ed obblighi nella successione della sovranità su un dato territorio. Questo lavoro è stato portato avanti dalla Commissione omonima, un organo sussidiario dell’ONU, e si è tradotto nella Convenzione di Vienna del 1978, e successivamente nei Trattati del 1983 e del 1986. L’unico neo alla sua concreta applicazione è stato il basso numero di ratifiche da parte degli Stati membri, limitatosi inizialmente a 20, vanificandone la completa entrata in vigore, e che denota ancora oggi la chiara difficoltà dei maggiori Stati-nazione mondiali a trattare il tema della secessione e dell’indipendentismo. Diversi altri enunciati internazionali continueranno a riprendere nel tempo il principio dell’autodeterminazione proposto da Wilson all’inizio del XX° secolo, come ad esempio gli Accordi di Helsinki del 1975, dove tuttavia l’obiettivo fondamentale era rappresentato dal miglioramento dei rapporti fra i Paesi NATO e quelli del Patto di Varsavia. Parallelamente, i movimenti indipendentisti nazionali non rimasero inerti e tentarono a più riprese forme di collaborazione internazionale. Peculiare in tal senso fu nel 1974 l’adozione della Carta di Brest, quando i movimenti gallese, occitano, bretone, basco, catalano, irlandese e Sardo (rappresentato da Su Populu Sardu) si riunirono per contestare l’imperialismo, sulla base di una visione marxista-socialista. In Europa tuttavia sorgevano partiti politici indipendentisti sovranazionali dediti a promuovere il tema dell’autodeterminazione, come l’European Free Alliance (Bruxelles, 1981), in cui aderirà anche il Partito Sardo d’Azione. Mentre più tardi il movimento Sardigna Natzione aderirà alle conferenze della CONSEU, una organizzazione dedita alla promozione delle tematiche dei popoli senza Stato dell’Europa occidentale. Sul piano legalitario, lentamente ratificato da numerosi Stati europei, nel quadro del vecchio continente si è consolidata la prassi avviata dalle Nazioni Unite in materia di rispetto delle minoranze (inizialmente con il Consiglio d’Europa, organizzazione esterna all’UE), sia relativamente ad una Carta delle lingue minoritarie (1992/1998), sia con la Convenzione-quadro delle minoranze nazionali (1991/1998), che si colloca sulla linea della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU, 1950). Mentre per l’UE gli standard odierni di tutela si collocano a partire dal Trattato di Nizza (2000), che istituì la Carta dei diritti fondamentali, sul solco della CEDU. Da segnalare inoltre la maggiore ONG internazionale nel campo dei diritti dei popoli senza Stato, l’UNPO, fondata nei Paesi Bassi nel 1991, che racchiude le rappresentanze di numerose minoranze etniche e nazionali, fra cui quella tibetana, abkhaza e taiwanese. Vi sono escluse tutte le partecipazioni politiche che includono l’uso della forza e del terrorismo come strumento di esercizio politico.
 Fra i maggiori movimenti indipendentistici democratici odierni vi è certamente quello della leader birmana Aung San Suu Kyi, che si batte per l’indipendenza del proprio popolo dalla giunta militare al potere. Abbiamo anche il movimento nazionale del Québec francofono, in Canada, mentre in Europa occidentale vanno segnalati quello scozzese e catalano. La battaglia autonomistica della Scozia ha consentito ad Edimburgo di avere un proprio Parlamento (Scotland Act, 1998), e di eleggere un proprio Governo con un Primo Ministro (attualmente la carica è ricoperta da Alex Salmond, leader dello Scottish National Party). La Catalogna, forte della sua tradizione linguistica, ha varato solo in anni recenti una riforma della propria autonomia nei confronti di Madrid, ed il governo nazionalista di Barcellona, come quello scozzese, si appresta ad affrontare un referendum sull’indipendenza. La Sardegna è stata amministrata da una forza indipendentista solamente per due mandati negli anni ’80, con la presidenza di Mario Melis del PSD’AZ, non riuscendo tuttavia a varare alcuna seria riforma istituzionale, anche a causa dell’ostruzionismo di PCI e DC.
Fra i maggiori movimenti indipendentistici democratici odierni vi è certamente quello della leader birmana Aung San Suu Kyi, che si batte per l’indipendenza del proprio popolo dalla giunta militare al potere. Abbiamo anche il movimento nazionale del Québec francofono, in Canada, mentre in Europa occidentale vanno segnalati quello scozzese e catalano. La battaglia autonomistica della Scozia ha consentito ad Edimburgo di avere un proprio Parlamento (Scotland Act, 1998), e di eleggere un proprio Governo con un Primo Ministro (attualmente la carica è ricoperta da Alex Salmond, leader dello Scottish National Party). La Catalogna, forte della sua tradizione linguistica, ha varato solo in anni recenti una riforma della propria autonomia nei confronti di Madrid, ed il governo nazionalista di Barcellona, come quello scozzese, si appresta ad affrontare un referendum sull’indipendenza. La Sardegna è stata amministrata da una forza indipendentista solamente per due mandati negli anni ’80, con la presidenza di Mario Melis del PSD’AZ, non riuscendo tuttavia a varare alcuna seria riforma istituzionale, anche a causa dell’ostruzionismo di PCI e DC.
Infine, per quanto riguarda il pensiero politico-filosofico ed economico, oltre al protagonismo comunista del secolo appena trascorso, dobbiamo considerare alcune delle teorie più importanti: quella liberale e libertariana. Nella fattispecie, importanti contributi al diritto all’autodeterminazione dei popoli sono arrivati dalla “scuola austriaca”, in cui si annoveravano liberali del calibro di Ludwig Von Mises e anarco-capitalisti come Murray Rothbard (schierato a favore del superamento completo dello Stato). L’economista Mises fu riconducibile alla corrente del miniarchismo, che comprendeva teorici come Herbert Spencer, Ayn Rand, Friedrich Hayek e Robert Nozick (teorico dello “Stato minimo”). Essi prospettavano uno Stato dalle funzioni ridotte ed essenziali, con la massima tutela per la proprietà privata. Fra i precursori di questa ideologia si citano il francese Frédéric Bastiat (1801-1850) ed il belga Gustave de Molinari (1819-1912).
 Dichiarò Mises: “Nessun popolo, così come nessun suo gruppo, dovrebbero essere trattenuti a forza, contro la loro stessa volontà, in un contesto politico ed istituzionale che essi non sentono proprio”. (Nation, State and Economy, 1919).
Dichiarò Mises: “Nessun popolo, così come nessun suo gruppo, dovrebbero essere trattenuti a forza, contro la loro stessa volontà, in un contesto politico ed istituzionale che essi non sentono proprio”. (Nation, State and Economy, 1919).
“Il diritto di autodeterminazione, per quanto concerne la questione dell’appartenenza allo Stato, non significa che questo: ogniqualvolta gli abitanti di un dato territorio – a prescindere che si tratti di un singolo villaggio, di un’intera contea, o di una serie di distretti contigui – hanno espresso, mediante il ricorso a libere votazioni, il desiderio di non voler più far più parte dell’ordinamento statale cui al momento appartengono, bensì di ambire alla costituzione di uno Stato autonomo, ovvero di venire a fare parte di un altro Stato, di queste volontà bisogna naturalmente tener conto. Questo è l’unico modo praticabile ed efficace per prevenire rivoluzioni, guerre civili e conflitti internazionali” (Liberalism, 1927).
Ed ecco Rothbard: “Il confine del tipico Stato nazionale è veramente così giusto (e così al di là di ogni cavillo) come la vostra o la mia casa, proprietà o fabbrica? Mi sembra che non solo il liberale classico o il libertario, ma ogni persona di buon senso che rifletta su questo problema debba rispondere con un sonoro «No». È assurdo designare in qualche modo giusto e sacrosanto ogni Stato nazionale, con i suoi confini autoproclamati esistenti ad ogni tempo dato e ciascuno con la propria «integrità territoriale» da preservare immacolata e salda come se si trattasse della vostra o mia persona fisica, della vostra o della mia proprietà privata. Invariabilmente, ben inteso, questi confini sono stati acquisiti con la forza e la violenza, o con accordi inter-statali stipulati al di sopra delle teste degli abitanti del luogo, e invariabilmente questi confini cambiano di molto nel tempo in modi che rendono veramente ridicole le proclamazioni di «integrità territoriale».” (Nations by Consent – Journal of Libertarian Studies, vol. 11, n. 1-1994).
Attualmente l’economista tedesco Hans-Hermann Hoppe ha rilanciato la soluzione dell’elvetizzazione, sul modello svizzero, ossia lo smantellamento dello Stato-nazione per arrivare alle piccole patrie, organizzazioni sociali in grado di assicurare un capace benessere economico unito al rispetto delle peculiarità linguistico-culturali, previo reciproco consenso.
Iscarica custu articulu in PDF
U.R.N. Sardinnya ONLINE – Natzionalistas Sardos












[...] – Vedi Parte 2: “Fra nazionalismo e cattolicesimo, alle radici del pensiero autonomistico“. [...]